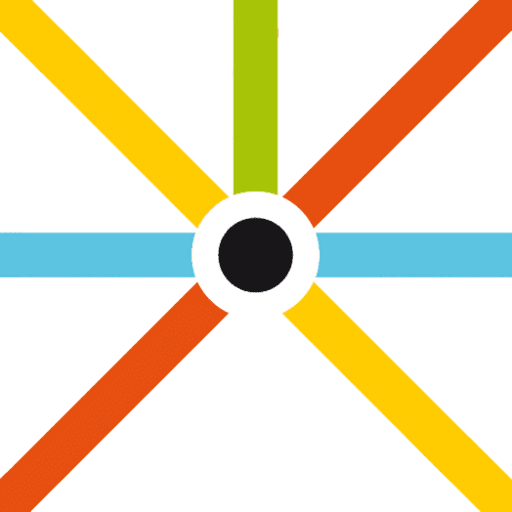– Di Andrea Spinosa –
Le infrastrutture accrescono il Pil – e non solo con i cantieri ma perché, se ben fatte rendono il Paese più efficiente – ma fare Pil con le infrastrutture è un mestiere complicato. Per procedimenti giudiziari, come a Palermo dove nei lavori per il passante ferroviario da 1,1 miliardi, si è aperto un contenzioso tra l’impresa, il Consorzio Sis, e l’ente appaltante Rfi, con la prima a chiedere extra-costi per 100 milioni di euro e il rischio, tuttora non risolto, di chiusura dei cantieri e rescissione del contratto.
Ma anche perché al Nucleo di Valutazione Investimenti che ad esempio opera per la valutazione dei progetti da finanziari nei “Patti locali” non arrivano idee che siano stato vagliate nella sostenibilità tecnica, socio-ambientale e finanziaria.
È un problema non da poco, per il Governo, perché si corre il rischio di non riuscire a centrare la clausola investimenti 2016 concordata con la Commissione europea, che in cambio di flessibilità di bilancio per lo 0,3% del Pil impegnava l’Italia spendere 4,2 miliardi di euro nel 2016 per investimenti co-finanziati da Bruxelles, e ad aumentare la spesa totale per investimenti rispetto al 2015, arrivando ad almeno 38 miliardi. Sul primo punto tirano bene le opere del Cef (grandi corridoi Ten-T), ma sono un po’ in ritardo quelle Fesr (fondi Ue per il Sud) e sono a zero quelle previste per il Piano Juncker (Pedemontana Lombarda e Veneta), mentre per la banda ultralarga il governo spera di strappare a Bruxelles come “spesa per investimento” il trasferimento di fondi a Infratel per le aree bianche.
Se Delrio, il giorno della sua nomina, parlava di fare la rivoluzione delle “Piccole opere”, quelle che cambiano la vita di tutti i giorni anche nelle medie città di provincia la mancanza di idee non aguzza l’ingegno e volente o nolente il Governo procede per opere che piccole non sono.
Ma torniamo alle nuove opere. Le due tratte ad alta capacità Milano-Verona e Verona-Padova fanno ancora parte del pacchetto di contratti Tav del 1991 a General Contractor, tuttora validi sebbene aboliti dal Nuovo codice degli appalti (DLgs 50/2016). La prima è di Cepav Due (Saipem 52%, Condotte, Maltauro e Pizzarotti al 12% ciascuno). La Verona-Padova di Iricav 2 (Astaldi al 37,49%, Salini Impregilo al 34,09 %, Ansaldo Sts al 17,05%, Condotte all’11,35%, Fintecna e Lamaro Appalti 0,01%).
Il progetto definitivo della Brescia-Verona (3.837 M€) andrà al Cipe alla prima riunione post-referendum: dopo la registrazione della delibera da parte della Corte dei Conti, Rfi e il contrante generale potranno firmare l’addendum contrattuale. Seguirà progettazione esecutiva, per fasi, e avvio dei lavori nella seconda metà del 2017. Poco più indietro il I lotto Verona-Bivio Vicenza, della Verona-Padova, che vale 2.790 M€. Il parere della Commissione VIA è atteso per fine novembre, la delibera Cipe potrebbe arrivare già a gennaio, con avvio dei lavori entro la primavera 2017. L’intera tratta Verona-Padova, con il nuovo progetto “leggero” per l’attraversamento di Vicenza, dovrebbe costare un po’ meno del previsto, 4,9 miliardi anziché 5,4.
Grandi opere anche al Sud: per le prime due tratte della Napoli-Bari, la Napoli-Cancello (813 M€) e Cancello-Frasso Telesino (730 M€), le gare d’appalto sono partite a luglio e si conta di aggiudicarle entro la primavera. Poi ci sarà da fare il progetto esecutivo, e l’avvio lavori è previsto nel corso del 2017. In avvio l’anno prossimo, infine, anche un tratto della Catania-Palermo raddoppiata e potenziata, la Bicocca-Catenanuova da 415 milioni. Rfi prevede la gara a inizio 2017, e l’avvio lavori entro l’anno: anche in questo caso sono tutte porzioni del futuro collegamento AV/AC Messina-Catania-Palermo.
E il resto?
Mancano le idee perché manca un metodo: la pianificazione non è una carta che si gioca al breve termine e il croupier passa la mano politica molto velocemente per pensare al domani.
1) CAPIRE LA DOMANDA
Primo passo: è necessario leggere i territori, scorgerne la domanda: non quella attuale, di chi usa i mezzi pubblici ma di quella di chi vorrebbe ma non può. È necessario, parlando di infrastrutture, studiare la stabilità della domanda e la sua evoluzione nel tempo: al 2020, al 2030 come saranno le città, cosa saranno diventate, di quali processi economici si alimenteranno?
Ogni amministrazione, ogni tecnico dovrebbe chiedersi: dove sarà la mia città nel 2030, quale posto occuperà nella koiné delle città internazionali. Perché per essere smart non serve approvare progetti, bisogna pensare smart!
2) TRASFORMABILITÀ DELLA CITTÀ
Secondo passo: è necessario costruire una carta della trasformabilità di una città. Individuare tutti i vincoli territoriali e raccoglierli in carte tematiche ognuno per proprio livello (layer): geomorfologia; idraulica (acque superficiali); idrologica (acque sotterranee); archeologia; tutela del paesaggio.
Così per le metropolitane i terreni duri avranno un livello di criticità più basso, quelli sciolti più alto; nell’idrologia gli acquiferi superficiali o i terreni permeabili saranno più sensibili delle zone con falda più profonda; nell’archeologia la presenza documentata di reperti saranno più sensibili di quelle libere o che nell’antichità risultavano acquitrinose ecc.
La sovrapposizione di questi layer (valutando una scala di priorità per ciascuno rispetto al rischio di dover indurre delle varianti in corso d’opera oppure di bloccare l’opera) porta, in una procedura che si chiama di overlay mapping, ad una carta della trasformabilità del territorio.
Un processo che vale sempre: per infrastrutture a raso, in viadotto o in galleria.
3) INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI
I corridoi di progetto nasceranno quasi in automatico dalla sovrapposizione delle linee di desiderio trasportistiche (le direttrici degli spostamenti lungo i quali le persone si spostano giornalmente) con questa carta della trasformabilità – secondo il principio del minimo costo (percepito) di viaggio porta all’individuazione di una serie di corridoi.
C’è sempre un lato soggettivo in tutto ciò perché la definizione finale delle alternative passa per scelte politiche sulla visione futura della città, sul valore assegnato ad un luogo rispetto ad un altro.
4) ANALISI DELLA ALTERNATIVE
Nel mondo ideale l’alternativa migliore è quella che incontra il punto di minimo di una superficie spaziale che vede nelle tre dimensioni: la riduzione del costo capitale; l’aumento del carico stimato (plafond, a capacità infinita); la riduzione delle esternalità e in particolare della spesa sanitaria indotta.
Tutt’altro che facile, ma un passaggio imprescindibile perché un progetto sia sostenibile nell’accezione più ampia del termine. E bancabile, infine.
A prescindere dalla voglia di tracciare segni sulla carta, seguire nella prima fase del processo decisionale un procedimento così rigoroso diminuisce il grado di soggettività delle scelte e rende il progetto scelto più resiliente in caso di difficoltà in corso d’opera.
Bisogna ricordare che nulla in Italia – almeno fino ai primi anni Duemila quando l’UE ha iniziato a rigettare le richieste di finanziamento senza una analisi preliminare su almeno 3 alternative -, è stato mai ponderato su una adeguata analisi decisionale.
5) TRA IL DIRE E IL FARE NON C’È PIÙ IL MARE
Lo abbiamo detto tante volte che l’Italia continua ad accumulare deficit in termini di spesa sanitaria futura perché ha un sistema della mobilità insufficiente e inadeguato. Abbiamo presentato una analisi comparata della produttività di nuovi sistemi di Trasporto Collettivo in Sede Propria in 671 aree urbane italiane ovvero di come si ridurrebbe la spesa pubblica con un massiccio investimento sulla mobilità pubblica. I risultati mostrano che è il momento di un accurato Piano Nazionale delle Città (quello che è mancato con le ex Legge 211/92) in cui si dettino le linee guida della mobilità di massa dei grandi centri urbani italiani. Perché stiamo parlando di un risparmio compreso tra 2 e 5 punti di PIL in 10 anni.
Ma è necessario che tutti facciano la propria parte: lo Stato assista e dia supporto, gli Enti locali che riprendano a pensare e progettare i territori.
Se non ora quando?
Intanto che ci pensate, proviamo noi a suggerirvi dove ci sono possibilità perché le idee che si arrovellano in testa a qualche tecnico dell’amministrazione possano diventare un progetto capace di camminare con le proprie gambe fino al Ministero dei Trasporti. Quelle “Piccole opere” di cui parlava il Ministro Delrio, forse.
Val d’Aosta: ripristino con servizio ferroviario leggero della ferrovia Aosta – Pré – Saint-Didier e realizzazione di un servizio vicinale in continuazione ovest verso Autoporto e Nus (Castello di Fenis)
Torino: riuso del sedime della vecchia linea per Ceres da Corso Giulio Cesare alla stazione Dora
Bolzano: tranviarizzazione del corridoio Metrobus per Caldaro ed eventuale connessione Stazione FS – Oltrisarco – Aeroporto – Laives.
Reggio nell’Emilia: progetto di riuso smart del sedime delle reggiane con risoluzione del salto di montone in stazione tra l’allineamento della linea per Ciano d’Enza e quella per Sassuolo con la linea per la Mediopadana, Bagnolo e Guastalla.
Modena: progetto di rilancio del Gigetto (il trenino per Sassuolo) con una nuova diramazione (singolo binario tranviario, diciamo leggero) da Formigine a Maranello (polo industriale e turistico dell’automobile) e Castelnuovo Rangone. A nord della città “idea” di messa a sistema del recupero del sedime della linea per Mirandola come azione di rilancio territoriale delle zone terremotate (con una robusta domanda pendolare e di sistema).
Pisa: implementazione della costruenda busvia per Cisanello con soluzioni smart per realizzare una connessione Stazione – via Bonanno Pisano (scuola di Ingegneria) – piazza Duomo – San Giuliano Terme e potenzialmente Lucca.
Perugia: tranviarizzazione della connessione FCU Perugia Sant’Anna – Ponte San Giovanni e approfondimento progettuale di inserimento di una prosecuzione urbana (tipo Valenciennes ligne 2) fino a Monteluce in sostituzione del progetto della linea 2 del Minimetrò e di potenziamento del carico giornaliero della esistente linea 1. Sfioccamento dei servizi ferrotranviari sul linea FCU Nord verso Ponte Valleceppi e Umbertide, a sud verso Deruta e Todi.
Pescara: riutilizzo intelligente (tant’é) anche alternativo al filobus della costruita e mai usata filovia Pescara Centrale – Montesilvano in un sistema Roseto – Pescara centro – Aeroporto – Chieti.
Bari: riuso delle connessione merci del porto e realizzazione di una prima linea tranviaria Stazione FS – Murattiano – Corso Vittorio Emanuele – Corso Vittorio Veneto – Fiera del Levante. Immissione (o affiancamento) da via Napoli sul sedime ferroviario per lo scalo Fesca – San Girolamo (interscambio con la “metro” per San Paolo) e prosecuzione verso Le Macche, Enziteto Catino (dove esiste un tronchino di attestamento e manovra) e Molfetta città. Continuazione verso sud sul tronco ferroviario RFI Bari Marconi – Bari Parco Sud che sarà presto dismesso (con una diramazione in afficamento al sedime FSE da Bari Mungivacca e nuovo tracciato lungo la Circonvallazione SS16 che andrà a riprendere la Bari-Lecce a San Giorgio). Realizzazione di servizi per Torre a Mare e Mola di Bari con recupero del vallo ferroviario di Japigia prima che questo sia perduto per una qualche malsana idea di boulevard senza TPL.
Lecce: efficientamento delle linee FSE prima che il loro esercizio in un refrain tutto italiano si riveli meno efficiente di quello di nuovi fiammanti bus.
Messina: messa a rete di quanto esistente (doppio binario per “metroferrovia” fino a Giampilieri Marina) linea 28 del tram che non carica a sufficienza, vecchio sedime della linea RFI per Villafranca Tirrena, buttata via con tanto di galleria sotto i popolosi quartieri pedemontani della città (le favelas, per capirci) come Rione Gongaza, Rione Bisconti e Contrada Faraone con realizzazione di una seconda linea tranviaria integrata alla prima.
Ragusa: potenziamento della fatiscente linea ferroviaria per servizi ferrotranviari tra le due parti della città e i popolosi comuni di Vittoria, Comiso e Modica (unico cluster urbano) e connessione in rete dell’aeroporto di Comiso (in via di potenziamento).
Sassari: aggiornamento e implementazione del progetto di tram-treno con immissione completa del pollicino sulla ferrovia vicinale per Sorso (da Santa Maria di Pisa), tranviarizzazione della ferrovia per Alghero e aggiornamento dello studio di fattibilità per una connessione all’aeroporto di Fertilia e al lungomare di Alghero (ipotizzate nel 2001, ma nei fatti niente più che un’idea).
E questo solo per iniziare: l’appetito vien pensando.